Con l’arrivo di questo mese, il caldo si fa deciso e stabile. Tutto è immagine dell’abbondanza, coi campi e gli alberi carichi di ortaggi e frutti succosi.
Luglio si chiamava anticamente Iulius, in onore di Giulio Cesare che nacque in questo mese. Un nome poco poetico, rispetto a quelli di molti altri mesi dell’anno, ma non per questo meno ricco di tradizioni interessanti, legate soprattutto al mondo agricolo e campestre.
Il mese è associato al numero sette, che simboleggia un ciclo che si compie e il conseguente rinnovamento in positivo. Sette sono i giorni della settimana, i pianeti dell’astrologia tradizionale, le note della scala musicale. Sette sono pure le lettere che compongono l’acronimo alchemico VITRIOL (Visita Interiora Terrae, Rectificando Invenies Occultum Lapidem). In Cina si ritiene che il numero sia legato alla vita della donna: a 7 mesi la bambina mette i denti da latte, a circa 7 anni li perde, in due volte sette anni le si apre la strada dello yin, ovvero raggiunge la maturità sessuale e a sette per sette, ovvero quarantanove, raggiunge la menopausa. Il sette è dispensatore di vita ed è la fonte di ogni cambiamento, difatti anche la luna modifica le sue fasi ogni sette giorni. Se si desidera cambiare qualcosa nella propria vita, dunque, Luglio è un mese propizio per farlo. Il sette rappresenta anche la totalità dello spazio e del tempo ed è il trionfo dello Spirito sulla materia. É numero di potenza, virtù e beatitudine.

Per i Celti l’8 luglio principiava il mese dell’Agrifoglio del calendario arboricolo Ogham. Dopo il Solstizio d’Estate siamo entrati nella metà oscura dell’anno e l’Agrifoglio è la pianta che dà il nome al sovrano di questi mesi che ci condurranno sempre più dentro noi stessi e che finirà per concentrare l’energia nelle radici e nel seme. Inizia, dunque, la lenta discesa del sole sull’orizzonte, le ore di luce cedono pian piano il passo a quelle di buio e oscurità, e anche la nostra energia, da questo momento in poi, sarà sempre più concentrata all’interno. Il Sole Bambino nato metaforicamente in noi col Solstizio d’Inverno è giunto alla sua essenza matura, alla pienezza dell’età adulta, che d’ora in poi stempererà in vecchiaia fino al prossimo Solstizio, quando si rinnoverà.
Tra le piante simbolo di luglio c’è sicuramente il grano, che già da giugno è divenuto protagonista di potenti riti arcaici che confluiranno, a fine mese, con la celebrazione di Lughnasad e Lammas, grandi feste del raccolto del mondo antico (per approfondire, puoi leggere l’articolo “Lughnasad e Lammas, feste del raccolto“). Il grano è simbolo del ciclo agricolo, rappresenta la vita e l’abbondanza, il sacrificio e la trasformazione, ed è il prodotto che più di ogni altro rappresenta la Madre Terra (per approfondire, puoi leggere l’articolo “Il pane di Lammas trasforma anche noi“).

La Grande Madre del Grano allestita per la festa di Triora Lammas 2018
E, a proposito di Dea Madre, in questo mese si celebrano due donne cristiane che molto hanno in comune con alcuni aspetti dell’antica divinità femminile. Il 22 luglio, infatti, è il giorno dedicato a Maria Maddalena, mentre il 26 a Sant’Anna.
La figura storica di Maria Maddalena è raccontata nei vangeli, nei quali ci viene detto che ella fu liberata da sette demoni grazie al Cristo (ritorna la simbologia del numero associato al mese di Luglio), fu la prima a cui apparve Gesù, risorto dalla morte. E qui ritroviamo già un primo sintomo di culti più antichi, come quello della divina Iside che, con la sua potente magia, consentì al suo amato sposo Osiride di rinascere, resurrezione di cui, per l’appunto, fu testimone (per approfondire, puoi leggere l’articolo “Iside e Osiride: un mito di resurrezione, iniziazione ed equilibrio“). Maria di Magdala, racconta la leggenda, non rifiutava al proprio corpo alcun piacere, caratteristica che le valse l’epiteto di peccatrice. Eppure anche in questo si trova un indizio assai importante della Dea antica e del suo culto, che promuoveva il piacere, anziché il dolore, e celebrava estaticamente la vita.
A Maria Maddalena è dedicata una grotta in Provenza, che secondo la leggenda fu abitata da lei negli ultimi anni della sua vita, una spelonca assai venerata dai fedeli, all’interno della quale sono presenti formazioni globulari che rimandano alla forma dell’uovo, simbolo del grembo materno e che rimandano alla Dea Uccello della preistoria; ancora in tempi recentissimi, all’esterno della caverna erano venduti reliquiari ovali che racchiudevano l’immagine della Maddalena (per approfondire, puoi leggere gli articoli “L’uovo della Rinascita” e “Riti sepolcrali preistorici in Valle Argentina – Nel ventre della Grande Madre“). In questo luogo dalle energie suggestive e arcaiche, Maria Maddalena è diventata patrona della fecondità, tanto da ricevere le richieste di aiuto da migliaia di donne a lei devote, che giungevano qui per ottenere il matrimonio e la fertilità per i loro grembi, con simboli arcaici legati esplicitamente ai culti della Grande Madre preistorica.

Maria Maddalena, Dante Gabriel Rossetti, 1857
Quanto a Sant’Anna, ella è protettrice delle partorienti e delle madri, delle ricamatrici e delle lavandaie, patrona delle donne che desiderano la maternità e dei minatori. Il colore del suo mantello, secondo i vangeli apocrifi, è di colore verde come i prati che ricoprono la terra, tinta, tra l’altro, associata al Chakra del Cuore. È raffigurata spesso come una Grande Madre che troneggia sulla Madonna e su Gesù bambino, formando una triade assai interessante, diretta discendente dei culti arcaici dell’antica Dea. In questa figura femminile cristiana riecheggia il culto di Demetra e Persefone, in cui la Madre genera la Figlia, che a sua volta dona vita alla Spiga di Grano (per approfondire, puoi leggere gli articoli “Demetra e Persefone e la promessa della rinascita” e “Giugno“).

Bassorilievo di Cerere Demetra
Un ulteriore indizio dell’arcaicità della figura di Sant’Anna è rappresentato anche dal suo stesso nome, che presenta la sillaba “an“, appartenuta a tutte le più grandi dee madri del mondo antico e che in sanscrito rimandava alla creazione di tutte le cose e alla prorompenza della vita, è principio vitale del cosmo, connesso anche alle acque. Non a caso Sant’Anna è collegata anche al mare. Più tardi, in lingua ebraica, il verbo hanàn significherà “concedere grazia” e Anna Perenna era pure una dea romana festeggiata durante il plenilunio alle Idi di marzo, divinità associata al perpetuo rinnovarsi dell’anno e all’inesauribile nutrimento offerto dalla terra. A tal proposito, gli induisti veneravano Annapurna, dea che incarna la luce che sazia ogni essere. Non solo nutrimento materiale, fisico, dunque, ma anche e soprattutto spirituale.
Nei culti e nelle feste di Maria Maddalena e Sant’Anna, quindi, troviamo molto delle energie del mese di Luglio e dei riti arcaici che in questo periodo dovevano svolgersi, interamente dedicati alla Terra e alla sua benedetta abbondanza, fonte di vita e sostentamento.

Il fiore del mese è il giglio bianco, insieme a quello che cresce spontaneo sulle spiagge sabbiose. La sua origine mitica è assai poetica, poiché si dice che nacque dal latte di Era, schizzato dal suo seno sulla terra e nel cielo. Le gocce terrestri fecero nascere i primi gigli, mentre quelle celesti diedero vita alla Via Lattea. L’Era dei primordi, che nulla aveva a che fare con la dea vendicativa e gelosa che ci viene tramandata anche dai testi scolastici, era ancora una volta riflesso della Grande Dea, madre di Vita (consigliata, a tal proposito, la lettura del saggio “Le Dee perdute dell’antica Grecia” di Charlene Spretnak). Il giglio, dunque, ne rappresenta il corpo fertile ed è diretto portavoce della fecondità della terra e del materno amore. Fu consacrato anche alla romana Giunone, assumendo il nome di Iunonia rosa. Rappresenta la procreazione, la bellezza, la verginità, la regalità e la ricchezza. Fu accostato anche a un’altra Madre, Maria, la piena di grazia, e perciò ispira la purezza dell’anima, la santità e la verginità che fu anche di altre dee del passato.
Nel mese di Luglio, infine, principia il segno zodiacale del Leone, segno di fuoco calmo e sovrano, come una fiamma viva e costante. Il leone era animale consacrato ad Atena, patrona delle arti, legata alla protezione della città. Passionale, incontenibile, esuberante, chi nasce nel segno del Leone è un tipo molto emotivo, forte, nobile d’animo, capace di sollevarsi dalle peggiori disgrazie, spinto dalla gioia di vivere, conviviale. È una forza della natura, nata per inneggiare alla vita, e per questo può essere idealista.

Col segno del Leone si entra nel periodo della canicola, il più caldo dell’anno. Il nome deriva dalla stella Sirio, protagonista dei cieli del periodo, facente parte della costellazione del Canis Major. Furono gli Egizi a definire il periodo contrassegnato da Sirio “canicola” perché, come un cane vigile, li avvertiva della benefica inondazione del Nilo che portava abbondanza e ricchezza, permettendo col suo limo ottimi raccolti.
Consapevoli delle energie di bellezza, pienezza e abbondanza del periodo corrispondente a questo mese, dunque, possiamo imparare a ri-allinearci con le vibrazioni cosmiche e terrestri, al fine di ritrovarle dentro di noi e manifestarle nella realtà, perché, ci tengo a ricordarlo, spiritualità e conoscenza non dovrebbero essere relegate unicamente alla cultura personale, ma applicate con dedizione alla vita quotidiana. A Luglio l’Universo ci parla di fecondità e ricchezza, le stesse che appartennero alle dee del passato: facciamole nostre, permettiamoci di sentirci esseri ricchi di luce e abbondanza divine, scintille feconde e condottiere dei fertili messaggi dell’Universo. Solo così il raccolto che in questo mese si manifesta nei campi potrà verificarsi anche dentro di noi, in una spirale di prosperità perpetua.
© http://www.spondediboscomadre.com
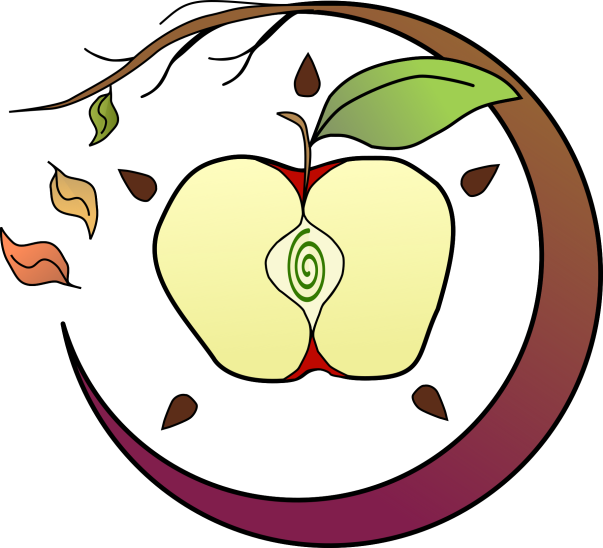
Le immagini prive di didascalia sono state tratte da Pixabay.

